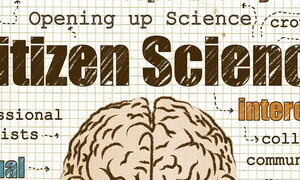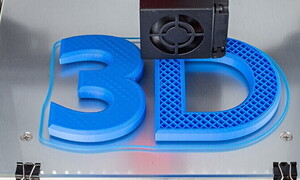Fast fashion, cosa si nasconde sotto i vestiti che indossiamo
10 GIUGNO 2024

Tra influencer che ci propongono le ultime novità in fatto di mode e il fiorire di grandi catene di negozi che vendono vestiti a buon mercato si è imposto un nuovo modello business basato sull’acquisto compulsivo di capi d’abbigliamento che negli ultimi decenni ha rivoluzionato il modo in cui ci vestiamo, generando però gravi problematiche a livello ambientale e sociale. Le parole usate per descrivere questo fenomeno sono fast fashion, letteralmente “moda veloce”, per indicare la velocità con cui le collezioni si rinnovano durante l’anno all’interno di un ciclo di produzione e consumo che, da un lato, spinge le case di moda a produrre a ritmi sempre più frenetici, e, dall’altro, i consumatori ad acquistare per rimanere al passo con le tendenze. Per incentivare l’acquisto di più capi di abbigliamento, inoltre, il prezzo di questi prodotti è spesso molto basso: questo ha un costo sociale molto alto che pagano i lavoratori e soprattutto le lavoratrici lungo la filiera. Il fenomeno della fast fashion ha trasformato i vestiti in articoli usa e getta, generando un grave problema nell’uso smodato di materie prime e nella produzione di rifiuti. Proviamo a scoprire come e dove vengono prodotti questi vestiti e, una volta che noi non li utilizziamo più, dove vanno a finire.
La produzione fast
Uno dei primi passi per comprendere questo fenomeno parte da un gesto molto semplice: guardare l’etichetta presente sui vestiti. Per produrre grandi quantità di indumenti, bisogna andare nei Paesi dove le materie prime e la manodopera costano poco, sulle etichette quindi si leggerà molto spesso che il nostro vestito proviene dal Bangladesh, Cambogia, Cina, Pakistan, India, Vietnam, Tunisia, Marocco. Questi sono solo alcuni esempi. Bisogna aggiungere che in alcuni di questi paesi spesso mancano leggi e controlli sulla tutela dei lavoratori e dell’ambiente. La lontananza tra il paese di produzione e quello dove il prodotto viene venduto rende più difficile controllare le filiere e così dalla coltivazione o dalla lavorazione della materia prima ci possono essere decine di passaggi, difficilmente tracciabili.
Sempre leggendo l’etichetta ci accorgeremo che i materiali che costituiscono le fibre degli abiti sono spesso misti: al cotone o alla lana viene aggiunto il poliestere o il nylon, tutti derivati dal petrolio. I capi sintetici, inoltre, durante il lavaggio, rilasciano milioni di particelle di microfibre di plastica, che finiscono nei mari. Queste minuscole fibre vengono ingerite dai pesci e dagli altri organismi marini, entrando così nella catena alimentare e arrivando persino sui nostri piatti. Le conseguenze a lungo termine di questa contaminazione sono ancora da valutare, ma destano grande preoccupazione.
Conseguenze a livello sociale
Come accennato all’inizio, produrre e vendere capi di abbigliamento a basso prezzo ha un costo sociale molto alto che pagano i lavoratori e soprattutto le lavoratrici lungo la filiera. Per esempio, nei Paesi dove si coltiva il cotone, come l’India, mantenere così bassi i prezzi mette a rischio di povertà estrema gli agricoltori. Si stima che le persone coinvolte nella filiera del tessile siano circa 75 milioni: queste persone che trasformano la fibra in filo e poi in tessuto e abiti ricevono salari molto bassi e hanno pochi diritti di tutela sul posto di lavoro.
La storia del Rana Plaza, la fabbrica crollata addosso ai suoi operai nel 2013 in Bangladesh, con le sue 1138 vittime e 2600 feriti ha mostrato nel modo più tragico cosa si nasconde dietro l’industria della moda: persone ammassate in un edificio fatiscente che sotto il peso dei macchinari è crollato su se stesso. Da allora, molti passi sono stati fatti, ma non abbastanza per garantire condizioni di lavoro sicure e salari dignitosi ai lavoratori e lavoratrici. Ancora oggi la filiera della fast fashion nasconde pesanti violazioni dei diritti umani fondamentali: riduzione in schiavitù, lavoro minorile, sfruttamento.
Conseguenze a livello ambientale
La produzione tessile è una delle industrie più assetate del pianeta. Per realizzare un solo paio di jeans possono servire fino a 7.500 litri d'acqua, sufficienti per il fabbisogno giornaliero di una persona per ben due anni e mezzo. Le coltivazioni di cotone, materia prima ampiamente utilizzata, richiedono un uso massiccio di fertilizzanti e fitofarmaci, un'irrigazione intensiva che impoverisce le falde acquifere e sottrae acqua ad altri usi essenziali. La tintura e la finitura dei tessuti, inoltre, impiegano una miriade di sostanze chimiche nocive, che spesso finiscono nei corsi d'acqua attraverso gli scarichi industriali. Queste sostanze tossiche contaminano l'acqua, danneggiano la flora e la fauna acquatica e possono entrare nella catena alimentare con conseguenze gravissime per la salute umana.
Bisogna infine aggiungere che l'obsolescenza programmata dei capi di abbigliamento e l'atteggiamento usa e getta tipico della fast fashion generano ogni anno quantità immense di rifiuti tessili. Si stima che circa l'85% dei tessili prodotti finisca nelle discariche, dove si accumulano in montagne che si decompongono con grande difficoltà o che permangono per decenni rilasciando microplastiche e sostanze nocive nel terreno e nelle falde acquifere.
Un cambiamento radicale
Per contrastare la fast fashion e sensibilizzare su ciò che accade realmente nel mondo della moda, da qualche anno è nato il movimento della Slow Fashion, che promuove una moda non compulsiva e che invita le persone a riflettere prima di comprare un capo di abbigliamento, per esempio chiedendosi se ciò che sto acquistando mi serve davvero e andando a controllare la qualità e i materiali che compongono il prodotto.
Si può inoltre verificare che sul capo d’abbigliamento ci sia il marchio Fairtrade Cotton. Questo marchio indica che il cotone utilizzato proviene da organizzazioni di agricoltori Fairtrade che si impegnano a rispettare rigorosi standard sociali e ambientali: utilizzo di acqua piovana per l’irrigazione, minimo utilizzo di prodotti chimici o agricoltura biologica. Esiste poi il marchio Fairtrade Textile Standard, che viene applicato ai tessuti e tutela l’intera filiera di produzione. Significa che le aziende vengono controllate per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, le condizioni dei luoghi di lavoro, la stipula di contratti regolari, un salario in linea con i contratti nazionali in modo che tutta la filiera sia tracciata e controllata. Purtroppo, è uno Standard esigente che ancora le aziende non hanno scelto di adottare perché implica un controllo accurato di tutti i passaggi della filiera da parte di un ente terzo come Fairtrade.
L'impatto ambientale della fast fashion è insostenibile e richiede un cambiamento radicale del modello produttivo e di consumo. È necessario adottare pratiche più sostenibili, come l'utilizzo di materiali ecocompatibili, l'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione degli sprechi. I consumatori, dal canto loro, possono fare la differenza scegliendo capi di qualità durevoli, acquistando da marche sostenibili e adottando un approccio più consapevole e responsabile agli acquisti. Ci sono innumerevoli esempi che dimostrano che è possibile creare prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Scegliendo con attenzione cosa acquistare e supportando le realtà virtuose, possiamo contribuire a costruire un futuro più verde per il pianeta e per noi stessi.
Per approfondire: